Il rigo gregoriano è composto di quattro linee e tre spazi.
Qualora il tetragramma non fosse sufficiente si aggiungono delle
lineette supplementari.
Sono due:
|
di Do |
 |
si trova sulla quarta o sulla terza linea (raramente sulla seconda) |
| di Fa |  |
si trova sulla terza o sulla seconda linea (raramente sulla quarta) |
Indicano, con la loro posizione, dove è posta nel tetragramma la nota relativa.
La guida (o custos) è una piccola nota posta alla fine di ogni rigo. Indica la prima nota del rigo seguente. Si può trovare anche a metà del rigo, quando c'è un cambiamento di chiave. Anche in questo caso indica la posizione della nota successiva.
Vi sono quattro tipi di stanghetta:
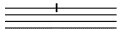 |
il quarto di stanghetta indica dove si può respirare senza che il canto subisca alcuna sospensione e la fine di un inciso musicale; |
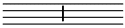 |
la mezza stanghetta indica dove si prende sufficiente respiro senza creare "tempi di silenzio" e la fine di una semifrase musicale; |
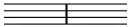 |
l'intera stanghetta indica una "pausa del valore di una nota" e la fine di una frase musicale; |
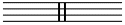 |
la doppia stanghetta indica la fine di un brano. All'interno di un canto indica l'alternarsi dei cori (Gloria e Credo). Nel caso vi sia un solo coro ha il significato di stanghetta semplice intera. |
Sono due e si trovano solamente davanti al Si: il bemolle e
il
bequadro
e
il
bequadro .
.
A volte, per esigenze tipografiche, le alterazioni vengono poste
davanti al neuma contenente il Si.
Il bemolle viene annullato:
Il bemolle può anche essere in chiave con significato moderno.
L'asterisco semplice : 
L'asterisco doppio : ![]()
![]()
Esistono tre tipologie di canto:
Il tempo può essere
L'allungamento di una nota dipende dal posto e dalla funzione della nota stessa nel contesto melodico e ritmico. Il riconoscimento delle note a tempo allungato è spesso facilitato dalla presenza di due segni:
 indica il raddoppio del valore;
indica il raddoppio del valore; =
=  =
= Vi sono comunque note che vanno allungate anche se prive dei segni citati:
Ogni nota, priva dei segni aggiuntivi, grande o piccola,
dentellata o inclinata, isolata o in composizione (purche' non
preceda il quilisma o lo stacco neumatico), deve essere
trascritta con valore di croma.
Il ritmo gregoriano si dice "libero". Ciò non
significa assenza di ritmo ma assenza di simmetrie obbligate. Il
testo del canto gregoriano è scritto in un latino che fa
riferimento all'accento tonico, che è l'elemento ritmico
pregnante. E' necessaria una dizione corretta del testo poiche'
la durata del neuma dipende dalla durata della fonazione della
sillaba ? "tempo sillabico". Per i melismi ci si basa
sull'analisi della scrittura. Ci sono delle interruzioni (stacchi
neumatici) che indicano la separazione tra blocchi melodici ai
quali fanno riferimento tempi sillabici medi.
| Punctum |  |
| Punctum inclinato |  |
| Virga |  |
Nell'edizione vaticana il punctum si trova sia isolato che in
composizione mentre la virga e il puncutm inclinato si trovano
sempre in "composizione" (quest'ultimo in composizione
discendente di almeno due note). Della virga esistono anche le
formazioni della bivirga (![]() ) e della trivirga (
) e della trivirga (![]() ). Si
trovano all'unisono, molto vicine tra loro e poste sulla medesima
sillaba. Nella pratica si eseguono due o tre suoni ripercossi
senza interruzione piuttosto pieni e robusti.
). Si
trovano all'unisono, molto vicine tra loro e poste sulla medesima
sillaba. Nella pratica si eseguono due o tre suoni ripercossi
senza interruzione piuttosto pieni e robusti.
| Pes |  |
(due note delle quali la seconda è la più acuta) |
| Clivis |  |
(due note delle quali la seconda è la più grave) |
| Torculus |  |
(la seconda nota è la più acuta) |
| Porrectus |  |
(la seconda nota è la più grave) |
| Climacus |  |
(tre o più note discendenti) |
Per indicare con esattezza il numero delle note che compongono
il Climacus, si dovrebbe dire: virga subbipunctis  ;
virga subtripunctis
;
virga subtripunctis  ; ecc.
; ecc.
Discorso a parte va fatto per lo Scandicus.
Genericamente per Scandicus si intende un gruppo di tre o più
note ascendenti.
 |
|
 |
| (a) | (b) | (c) |
| a) | a note unite (munite in questo caso di episema) = tre note leggermente allargate |
| b) | con stacco iniziale * (la prima nota è staccata
per indicare la maggiore importanza; si esegue con leggero appoggio ed
allungamento, le altre senza impulsi); *) : Nella versione vaticana lo stacco non esiste quasi più, ma alla mancanza si supplisce con l'aggiunta di un episema orizzontale sulla prima nota, ottenendo, in pratica, lo stesso effetto. |
| c) | con virga terminale (la seconda nota è particolarmente importante quindi si esegue con appoggio ed allungamento proporzionato all'ampiezza dell'intervallo [quarta e quinta sono più importanti dell'intervallo di terza] ). |

(Questa forma con stacco sarà vista al momento
dello studio particolareggiato dello stacco neumatico).
A note unite : con più di tre note, allo stato isolato e
su una sola sillaba si trova raramente. Di solito sono note
leggere, ma, per l'esatta interpretazione è indispensabile la
lettura dei manoscritti.
|
|
= |
 |
|
|
= |
|
Il salicus è un gruppo di tre o più note ascendenti con
le
ultime due in forma di pes e la penultima munita di trattino
verticale (ictata). Il salicus rappresenta un'interpretazione
particolare dello scandicus. La nota caratteristica del salicus
è quella munita di episema verticale. La particolarità
del
salicus è di portare la melodia verso l'apice, da non trascurare
nell'interpretazione. Quindi anche la nota che segue quella
episemata (che è la più acuta) , dovrà essere
eseguita con
ampiezza.
Quando il salicus è in composizione, la nota caratteristica (quella ictata), prepara all'appoggio della nota seguente che è esteticamente più importante. La vera funzione del salicus è quindi di portare avanti il flusso melodico.
I neumi speciali sono : Quilisma, Oriscus, Salicus, neumi liquescenti, Strophicus, Bivirga e Trivirga, Pressus.
 |
E'una nota dentellata, legata ad una virga superiore e quindi
sempre in un gruppo ascendente. Esiste un'analogia tra il salicus
ed il quilisma in quanto in ambedue la nota caratteristica porta
alla nota seguente che è più acuta e di maggiore
importanza
melodica; la differenza sta nel fatto che, mentre nel salicus
anche la nota caratteristica richiede un certo appoggio
intensivo, nel gruppo quilismatico la nota speciale è più
debole e leggermente sfuggita. Si allunga sempre la nota che lo
precede e, in genere, viene eseguito in crescendo. Dal punto di
vista modale si può giustificare la differenza tra salicus e
quilisma in quanto quest'ultimo, a differenza del salicus, si
trova sovente su gradi non importanti (spesso sulla
sottodominante che tende logicamente alla dominante stessa).
Come regola semplice e pratica per
l'individuazione dell'oriscus nella notazione vaticana, possiamo
dire che: l'oriscus è la nota speciale, per lo più
all'unisono,
che termina un gruppo neumatico (contigua ma distinta e sempre
sulla stessa sillaba).
 |
 |
| ut | et |
| L'oriscus è il neuma grigio | |
Produce un suono delicatissimo che per taluni può essere legato
alla nota precedente. Non porta l'ictus che invece indica
l'inizio di un altro neuma. Nella notazione vaticana l'oriscus è
scritto indistintamente con un punctum o con una virga; ne
risulta che non è più individuabile quando, invece di
essere
all'unisono, si trova su un grado più elevato dell'ultima nota
di un gruppo.

Sebbene taluni tendano ad eseguire la virga come fosse un oriscus, la migliore interpretazione è quella di ripetere la nota.
Il salicus si presenta in due modi:
Con tutte le note ascendenti: che abbiamo già visto e che può essere formato da tre o più note.

Salicus all'unisono: formato da un punctum all'unisono con un pes. La nota caratteristica è la seconda all'unisono. Si trova specialmente nel terzo e quarto modo.

Al fine di distinguerlo dalla virga-pes all'unisono, diremo che il salicus all'unisono comporta la ripercussione leggera della seconda nota, mentre la virga-pes all'unisono viene eseguita con la fusione in un solo suono pesante della seconda nota all'unisono (a mo' di pressus).
Tutte le note che si incontrano all'unisono sulla stessa
sillaba vanno ripercosse tranne:
Viene così definito il neuma (qualunque esso sia) che termina
con una nota rimpicciolita, la quale viene eseguita più
debolmente.
Nella notazione quadrata è rimasta solo la liquescenza diminutiva
(prima c'era anche quella aumentativa).
E' il termine generico per indicare due tra le formazioni più caratteristiche dell'apostropha.
![]()
Tristropha: tre note vicine, all'unisono (oppure due note all'unisono precedute da una più grave), sia in composizione che non.
 , , |
 . . |
Sebbene taluni tendano ad unire in un unico suono le due o tre note, è bene eseguire le note ripercosse e leggere.
Bivirga : due note vicine, all'unisono, isolate su una
sillaba;
Trivirga : tre note vicina all'unisono.
A differenza delle leggere ripercussioni delle distrophe e
tristrophe, nella bivirga e trivirga, le note ripercosse sono
pesanti e comportano una certa ampiezza.
La notazione vaticana, per indicare l'apostropha, usa il segno
generico di punctum. Le eventuali esitazioni nel riconoscere i
raggruppamenti vengono spesso superate grazie all'ictus, che ne
indica l'inizio.
 |
 |
| torculus,tristropha | clivis,distropha |
 , , |
 |
Neuma formato essanzialmente da tre note: le prime due
all'unisono (vicine e sulla stessa sillaba) e la terza
(appartenente allo stesso neuma ed alla stessa sillaba) più
grave. Il pressus si presenta in due modi:
Una nota (punctum o virga) all'unisono davanti ad un gruppo nel quale almeno la seconda nota sia melodicamente più grave
![]()
![]()
Secondo la prassi più comune le due note all'unisono che
formano il pressus vengono fuse in un solo suono da eseguirsi con
pienezza e vigore.
Non abbiamo pressus quando:
- i due gruppi sono spaziati;
- è presente l'ictus (che indica l'inizio di un nuovo gruppo);
- il secondo gruppo non è discendente.